Il Tractatus Logico-Philosophicus di Ludwig Wittgenstein non è semplicemente un libro; è un monumento intellettuale, un enigmatico e audace tentativo di delineare i limiti del linguaggio e del pensiero.
Pubblicato per la prima volta nel 1921 (con l'introduzione di Bertrand Russell), quest'opera concisa ma densissima rimane uno dei testi più influenti e dibattuti della filosofia del XX secolo. Il libro affascina e intimorisce fin dal titolo, così severo e ultimativo.
La Verità deve interessare sopra ogni cosa: ma il rischio più frequente è che finiti gli studi e abbandonata la vita studentesca, le necessità della vita adulta e le abitudini sociali sommergano il bisogno di verità fino a farlo dimenticare.
Perfino coloro che esercitano una professione intellettuale sono spesso spinti proprio dagli ambienti e dalle istituzioni in cui lavorano a tradire i valori della loro vocazione originaria.
La vita di Wittgenstein è stata un esempio del contrario, quasi che quest'uomo non abbia mai smesso di essere un adolescente idealista, solitario e selvatico, dominato da una passione teoretica e morale che non gli dava pace.
Ciò che più colpisce è il linguaggio. Il rigore estremo con cui si è proposto di usarlo per impedire che fosse una lingua imprecisa e non onesta a produrre idee false e falsi problemi filosofici. Il suo programma è stato sempre quello di purificare, bonificare i territori del linguaggio filosofico tradizionale, in cui si era parlato di cose non chiaramente pensate né forse pensabili. L'insieme delle proposizioni o aforismi del Tractatus doveva essere secondo Wittgenstein uno specchio del mondo.
La prima frase è questa: «Il mondo è tutto ciò che accade» e poi più avanti: «L'immagine logica dei fatti è il pensiero».
L'obiettivo principale di Wittgenstein è stabilire cosa può essere detto significativamente e cosa, invece, deve rimanere inesprimibile. La sua tesi centrale è che il linguaggio raffigura il mondo.
Le proposizioni, per Wittgenstein, sono come immagini (o "figure") dei fatti. Attraverso una serie di aforismi numerati (da 1 a 7, con sottosezioni), egli costruisce una complessa impalcatura logica per spiegare come il linguaggio funziona e come, di conseguenza, la realtà è strutturata.
Ciò che colpisce immediatamente del Tractatus è il suo stile lapidario e apodittico. Non ci sono argomentazioni prolisse o spiegazioni dettagliate; Wittgenstein espone le sue tesi con una precisione quasi matematica, lasciando al lettore il compito di districare le implicazioni profonde di ogni affermazione. Questa concisione, se da un lato è fonte di ammirazione, dall'altro rende il testo notoriamente difficile e a tratti impenetrabile. Ogni frase è carica di significato e richiede una profonda riflessione per essere assimilata.
Al centro della sua analisi vi è la distinzione tra ciò che può essere "detto" (il dominio della scienza e della logica) e ciò che può solo essere "mostrato" (il dominio dell'etica, dell'estetica e del mistico).
Le proposizioni della logica e della matematica sono tautologie, esse non dicono nulla sul mondo ma mostrano la sua struttura logica. Le proposizioni significative, invece, sono quelle che possono essere vere o false. Ma per Wittgenstein, le questioni più profonde dell'esistenza – il senso della vita, i valori morali, il sacro – non possono essere espresse linguisticamente. La celebre conclusione - sotto riportata - riassume l'intento terapeutico dell'opera: purificare il linguaggio dalle pseudo-problemi filosofici che sorgono quando cerchiamo di dire l'indicibile.
«Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen - Su ciò di cui non si è in grado di parlare, si deve tacere».
Tale aforisma non è un'imposizione a tacere, non è una censura alla Parola, è piuttosto un invito a far tacere il fracasso interiore, specie in questi tempi di dittatura del rumore e di iperfrenesismo. Davanti al Mistero la parola si riconosce depauperata del suo potere evocativo, per poter rendersi almeno po' isomorfa all'Indicibile, per poter esprimere l'Inesprimibile, deve immergersi nel loquace silenzio dell'Inafferrabile, solo allora purificata e rigenerata riesce a farsi illuminare dal Mistero e renderlo scibile alla nostra ragione.
Il Silenzio è il frutto di un impegno, è ferrea disciplina, il risultato di una coltivazione, non qualcosa che si dà automaticamente. Solo dal Silenzio nasce la Parola che dà forza al nostro cuore e trasforma il nostro, semplice, essere al mondo in Vita Piena.
L'impatto del Tractatus è stato enorme, influenzando il positivismo logico del Circolo di Vienna e l'intera tradizione della filosofia analitica. Tuttavia, la sua interpretazione è stata ed è ancora oggetto di feroci dibattiti. Alcuni lo vedono come un rigoroso trattato di logica e filosofia del linguaggio, altri come un'opera profondamente mistica che usa la logica per mostrare i limiti della stessa e aprire la via a ciò che è oltre il dicibile.
Il Tractatus Logico-Philosophicus è consigliato a chiunque sia seriamente interessato alla filosofia, alla logica e ai fondamenti del linguaggio. Preparatevi a un viaggio impegnativo ma incredibilmente gratificante. Non è un libro da leggere con leggerezza, ma da studiare, meditare e, forse, confrontarsi con i propri limiti concettuali. È un testo che, a distanza di oltre un secolo, continua a sfidare e ispirare, ricordandoci la potenza e i confini del nostro stesso pensiero.
Antonio Vigliotta
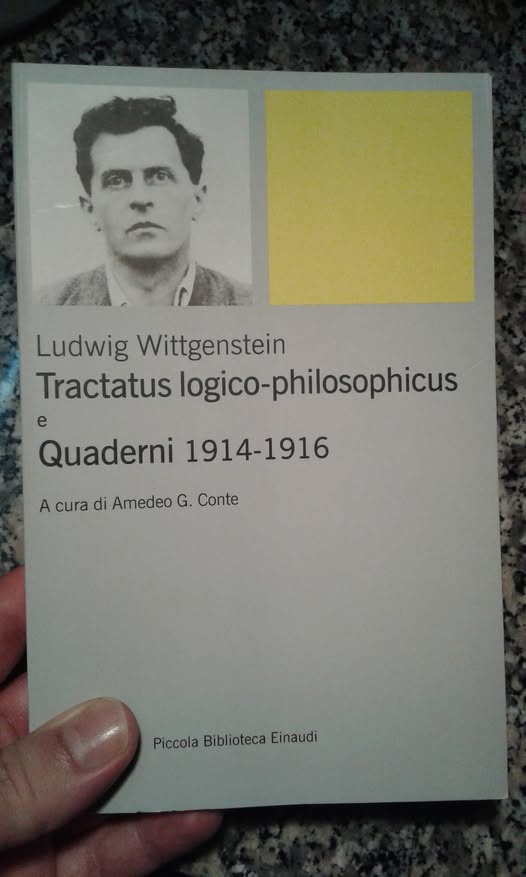
NDR E' uno dei pochi libri che non sono riuscito a terminare
24 agosto 2025
Impresa Oggi
