Il sovrano si rivolge al mercante e con atteggiamento benevolo e disponibile gli chiede: «Che cosa posso fare per voi?» Il mercante risponde:
«Maestà, dateci buona moneta e strade sicure, al resto pensiamo noi»
Kant
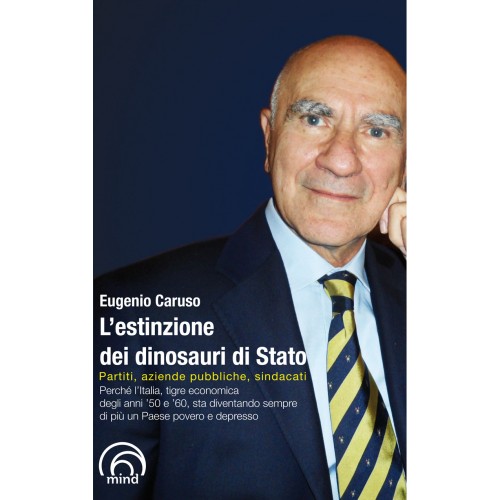
Con questo quinto articolo proseguo la pubblicazione di alcuni stralci del mio libro storico-economico L'estinzione dei dinosauri di stato. Il libro racconta i primi sessant'anni della Repubblica soffermandosi sulla nascita, maturità e morte delle grandi istituzioni (partiti, enti economici, sindacati) che hanno caratterizzato questo periodo della nostra storia. La bibliografia sarà riportata nell'ultimo articolo di questa serie. Il libro può essere acquistato in libreria, in tutte le librerie on-line, oppure on line presso la casa editrice Mind.
Per il Capitolo IV clicca QUI.
CAPITOLO II - IL CENTRO SINISTRA (1961-1976)
Nel marzo del 1961, al XXXIV congresso del partito, i socialisti optano per la scelta di campo occidentale, ponendo le premesse per il loro coinvolgimento nel Governo o, come afferma Nenni, per far entrare «nella stanza dei bottoni» i rappresentanti delle masse popolari. Peraltro, nel luglio del 1961, i socialisti tolgono l’appoggio esterno al Governo delle convergenze parallele, chiedendo alla DC il superamento della politica degli Esecutivi centristi.
La situazione politica è in ebollizione, davanti e dietro le quinte si gioca la battaglia per l’ingresso dei socialisti al Governo, osteggiato da Chiesa e Confindustria e appoggiato dagli intellettuali, dall’industria di Stato e da gran parte della DC, che vede nel centro-sinistra la prospettiva di una maggiore stabilità di Governo. I dorotei guidati da Moro, dopo le elezioni amministrative dell’ottobre 1960, avviano un’intesa con il Psi per realizzare giunte di centro-sinistra (Milano, gennaio; Genova, febbraio; Firenze, marzo). Il consigliere particolare di Kennedy, lo storico Arthur Schlesinger e l’inviato speciale Averell Harriman convincono il Presidente degli Usa che il centro-sinistra potrebbe dare all’Italia un Governo più riformista e consentire d’isolare il Pci; Schlesinger, nel suo libro I mille giorni di John F. Kennedy, racconta che, da un certo momento, emissari di Kennedy a Roma fecero pressioni per accelerare l’ingresso dei socialisti al Governo. A Napoli, all’ottavo congresso DC, nel novembre 1962, l’asse Moro-Fanfani è in grado di convincere i colleghi di partito che la politica non premia più il centrismo: l’80% dei delegati, anche la destra vaticanista di Andreotti, appoggia la lista Amici di Moro e Fanfani, decretando ufficialmente lo spostamento dell’asse politico a sinistra. Solo il gruppo di Scelba mantiene la sua opposizione. Andreotti, pur accordandosi con Moro e Fanfani, mantiene una posizione defilata; ammetterà, molti anni dopo, di non aver creduto, allora, nella validità della strategia dell’isolamento del Pci, strategia che avrebbe allontanato il processo di liberazione dei comunisti dal vincolo di fedeltà con il Pcus (Zavoli, 1999).
Nello stesso 1962 inizia quindi, cautamente, l’esperimento del centro-sinistra, a livello nazionale. Amintore Fanfani, forma il suo quarto Governo (21 febbraio 1962-21 giugno 1963), un tripartito DC, Psdi, Pri con l’appoggio esterno dei socialisti: il cosiddetto Governo di “centro-sinistra programmatico”. L’appoggio esterno del Psi è determinante e contrattato sulla base di un programma che comprende: nazionalizzazione dell’industria elettrica, istituzione della scuola media unica, istituzione delle Regioni. Il centro-sinistra nasce tra apparenti grandi entusiasmi, ma con un difetto di fondo: ingloba aspettative troppo diverse (Galli, 1996), quella dei riformisti (La Malfa, Saraceno), che propongono «riforme correttive al caotico sviluppo del capitalismo italiano», quella dei socialisti, che considerano il centro-sinistra l’humus per «preparare la strada alle riforme strutturali e al socialismo», quella minimalista dei dorotei, che accettano una politica riformista solo nella misura in cui essa non intacchi il potere della DC.
Segni alla Presidenza della Repubblica
Nel mese di maggio 1962 deve essere eletto il Presidente della Repubblica. Moro si rende conto che è necessario puntare su un personaggio che, nei confronti dei moderati, sia garante del centro-sinistra e, pertanto, si impegna per la nomina di Antonio Segni. La sinistra DC, che teme un eccessivo rafforzamento dei dorotei, e i gronchiani, che puntano alla riconferma, fanno resistenza, mentre la sinistra vota per Saragat. Solo al nono scrutinio l’abilità di Moro è premiata e Segni, il 6 maggio 1962, viene nominato Presidente con il voto determinante dei monarchici e dei missini. «Ad Aldo Moro, molto più che al neo-Presidente della Repubblica, andò, non a caso, la lunga ovazione del Parlamento, che riconobbe il vero vincitore» (Cossiga, 2000).
La Rai di Ettore Bernabei
Alla fine del 1960 il fanfaniano Ettore Bernabei, dopo essere stato direttore del Giornale del mattino di Firenze e del Popolo, organo ufficiale della DC, viene nominato direttore generale della Rai; la nomina viene direttamente da Fanfani. Bernabei diventerà uno dei più potenti boiardi di Stato e dirà di sé: «Il mio modo di essere eminenza grigia era di stare dietro le poltrone di chi pigiava i bottoni». La gestione della Rai di Bernabei, che durerà fino al 1974, può essere raccontata con alcuni numeri: nel 1961 i giornalisti erano 400 e i dipendenti 4.000, nel 1974 saranno rispettivamente 800 e 12.000. Si apre la stagione dei romanzi sceneggiati e dei telefilm americani; la satira deve essere rispettosa della Chiesa e della politica.
L’azienda diventa un “raccomandificio”: arrivano 20mila lettere di raccomandazione all’anno, senza contare le telefonate che, come racconta lo stesso Bernabei, contano molto più di una raccomandazione scritta. Le assunzioni avvengono secondo la tessera di partito, su cinque assunzioni tre vanno ai democristiani, due agli altri; per Bernabei, inoltre, è necessaria un’altra qualità, il candidato deve credere in Dio. Le massicce assunzioni, per ammissione dello stesso Bernabei, servono per diluire nel mare del centro-sinistra la vecchia classe dirigente fascista e massone. Direttore del telegiornale, dopo le brevi parentesi di Enzo Biagi e Giorgio Vecchietti, viene nominato Fabiano Fabiani, che diventerà un altro potentissimo grand commis.
Bernabei, come democristiano, fa in Rai gli interessi della DC, perché è convinto che questi coincidano con gli interessi del Paese. D’altra parte «[…] poiché ogni ordine di servizio, grande o piccolo, era carico di risvolti politici, bisognava che non incontrasse l’ostilità dei partiti […] senza il consenso sostanziale del Governo e delle principali forze politiche, compresi i comunisti, era impossibile procedere» (Bernabei, 1999). Successore di Bernabei, dopo la prematura scomparsa di Willy De Luca, sarà il demitiano Biagio Agnes, che completerà lo spostamento a sinistra della dirigenza Rai, favorendo il definitivo controllo da parte del Pci della terza rete. Affermerà Bruno Vespa, ancora nel 2002: «I continui ribaltamenti del fronte politico hanno prodotto nella Rai sedimentazioni diverse e variabili, ma il nocciolo duro è ancora sostanzialmente costituito da cattolici di sinistra ed ex comunisti» (Vespa, 2002).
La nazionalizzazione dell'energia elettrica e la nascita della nuova Sip
Nel dicembre 1962 è approvata la nazionalizzazione dell’energia elettrica. Viene coronata da successo la campagna, avviata nel 1955 dagli Amici del Mondo, e sostenuta successivamente da Riccardo Lombardi, Antonio Giolitti, Pietro Nenni, Emilio Colombo ed Enrico Mattei. Le società elettriche private avevano cercato di giocare la carta dell’innovazione e della ricerca nucleare per mostrare che la loro non era una pura rendita di posizione, ma alla fine, tra l’approccio programmatorio e quello di mercato, prevale il primo. Pianificazione e benefici sociali vengono preferiti a competizione e profitto, l’impostazione liberista del primo dopoguerra è abbandonata. Quel che appare subito chiaro è che, con la nomina a presidente dell’Enel del democristiano Vitantonio Di Cagno e a vicepresidente del socialista Luigi Grassini, inizia ufficialmente l’era delle lottizzazioni e dei boiardi nel sistema energetico nazionale.
La lottizzazione all’Enel ha caratteristiche precise; il consiglio di amministrazione è composto da soggetti espressione dei partiti di Governo e di opposizione, a ciascun consigliere è affidata un’area di responsabilità, con tanto di deleghe, cosicché l’ente risulta articolato in tante sotto-aziende a capo di ciascuna delle quali si trova un consigliere con compiti molto vicini a quelli di un vero e proprio amministratore delegato. Il capitalismo manageriale di Stato per il nuovo ente elettrico parte subito azzoppato.
Completata la nazionalizzazione dell’Enel, viene deliberata la fusione per incorporazione nella Sip delle cinque società telefoniche concessionarie (Stipel, Telve, Timo, Teti e Set). L’operazione si concluderà solo nel 1994. Dopo le incorporazioni di Italcable (servizi intercontinentali), Sirm (comunicazioni radiomarittime), Telespazio (collegamenti via satellite) e Iritel (interurbane di lunga distanza e internazionali continentali), la Sip diventa l’unico gestore nazionale delle telecomunicazioni, prendendo la denominazione di Telecom Italia. Sono state preparate un bel po’ di poltrone per i prossimi partner di Governo: i socialisti.
I socialisti entrano “nella stanza dei bottoni”
Alle elezioni del 28 aprile 1963 la DC perde voti a favore del Pli, che ha cavalcato la protesta per la nazionalizzazione delle imprese elettriche e per l’apertura al Psi; il Pci sale a quota 25,3% e il Psi subisce una leggera flessione (13,8%). La DC attribuisce la sconfitta al dinamismo riformatore di Fanfani, che si dimette, anche per le dure critiche di Saragat, il quale lo accusa «di gravi errori di direzione politica». La DC pone condizioni al Psi, in particolare chiede garanzie sulla difesa della proprietà privata. Nella notte tra il 16 e 17 giugno a Nenni viene a mancare la maggioranza del comitato centrale, per la ratifica dell’intesa con la DC, cosicché la responsabilità del fallimento dell’intesa per realizzare il centro-sinistra ricade sui socialisti. In attesa del XXI congresso del Psi viene pertanto varato il monocolore retto da Giovanni Leone “di transizione” (21 giugno-4 dicembre 1963).
Il 3 giugno 1963 muore papa Giovanni XXIII, due anni prima della fine del Concilio Vaticano II. Dopo il “papa buono” i cardinali si assicurano un pontefice più tradizionalista e “cresciuto in Curia”. Viene eletto, infatti, Giovanni Battista Montini, che prende il nome di Paolo VI: il nuovo papa affermerà che con il Concilio Vaticano II nella Chiesa era entrato insieme «all’aria fresca, il fumo di satana».
Al congresso del partito socialista, l’asse Nenni-De Martino-Lombardi si ricompone; prevale la posizione di Nenni che privilegia la formulazione politica del centro-sinistra all’imposizione di un programma di riforme. Leone si dimette e le trattative per il centro-sinistra si concludono positivamente. È il 23 novembre, poco dopo l’uccisione di Kennedy. Uno shock che sconvolge il mondo e che in Italia porta ad accelerare le trattative per il primo Governo di centro-sinistra. I socialisti, nel dicembre 1963, entrano quindi nel primo gabinetto Moro (DC, Psi, Psdi, Pri), detto “di centro-sinistra organico” (4 dicembre 1963-22 luglio 1964); vicepresidente del Consiglio è Nenni, Saragat è ministro degli Esteri, il repubblicano Oronzo Reale è alla Giustizia, Taviani agli Interni, Andreotti alla Difesa, Colombo al Tesoro, Giolitti al Bilancio. Il leader dei dorotei, Mariano Rumor, diventa segretario della DC.
Il Psi perde la sua ala sinistra, che fonda il Partito Socialista di Unità Proletaria, e si attesta su una percentuale del 10%. La scissione della sinistra è in linea con la politica fratricida, frazionistica e dell’egoismo ideologico
che caratterizza la storia del socialismo italiano; lo Psiup, inseguendo i miti dell’anticapitalismo, accumulerà un piccolo patrimonio di voti, che servirà a tener in vita se stesso, ma condannerà il Psi a giocare un ruolo minore nei riguardi della DC.
La nascita del primo Governo Moro avviene in un periodo di cattiva congiuntura economica, i tempi non sono quindi propizi per avviare programmi di riforme. Da quel momento, e per circa un decennio, la politica economica sarà guidata dal governatore della Banca d’Italia, Guido Carli e dal ministro del Tesoro, Emilio Colombo (la cosiddetta linea Colombo-Carli) e sarà una politica deflazionistica resa necessaria dagli inconvenienti derivanti dai rinnovi contrattuali del 1962-1963.
Un aspetto contraddittorio della politica del Psi è che, mentre a Roma è alleato alla DC, nelle amministrazioni locali – come Firenze e Bologna – è alleato del Pci. Questo comportamento viene da molti italiani interpretato come una “fame di incarichi”; probabilmente, il Psi pagherà questa cultura del doppiogioco in termini di credibilità, non riuscendo mai a superare la soglia del 15%, neanche nei ruggenti anni del craxismo. Il Pci è ufficialmente contrario al centro-sinistra, che viene visto come un tentativo di dividere la classe operaia, ma Togliatti mostra il solito realismo, affermando che la formula politica è anche un’opportunità «per rompere il blocco conservatore» e, in occasione della fiducia al Governo Moro, preannuncia un’opposizione morbida e costruttiva: i contatti e i giri di valzer tra Pci e sinistra DC diventano sempre più frequenti.
I socialisti e l’impatto con il mondo dell’economia e delle imprese
Quando, nel 1963, i socialisti entrano nel Governo, il quotidiano confindustriale 24 Ore denuncia che «gli imprenditori potrebbero trovarsi di fronte a prospettive non dissimili da quelle dei loro colleghi cecoslovacchi, ungheresi e cinesi», mentre l’Avanti esce con il titolo: «Da oggi ognuno è più libero». La realtà darà torto a entrambi, in particolare l’auspicio dell’Avanti si rivelerà presto solo un’illusione. Verso la fine degli anni Se ssanta inizierà infatti l’era del manuale Cencelli, che regolerà l’attribuzione di “porzioni di Stato” ai partiti o alle correnti di partito. L’introduzione di un linguaggio, poi soprannominato politichese, segnerà la definitiva separazione tra la gente e la politica.
La DC, stroncando le resistenze di Ugo La Malfa, che credeva nell’industria di Stato come elemento di rafforzamento dell’economia di mercato e non come centro di potere, portò avanti la politica fanfaniana che intendeva le partecipazioni statali come strumenti di finanziamento dei partiti, politica che condusse alle croniche perdite di bilancio dell’Iri e alla degenerazione dell’Egam e dell’Efim, degenerazioni che rasentarono il ridicolo se non fossero risultate tragiche; ai tecnocrati vennero preferiti i grand commis, la cui principale expertise era quella di saper curare i rapporti politici.
L’Egam (Ente Gestione Attività Minerarie) era un ente pubblico nato nel 1958 con lo scopo di gestire tutte le produzioni minerarie italiane. In realtà rimase inoperante fino al 1971, quando, presieduto da Mario Einaudi, assunse il controllo di numerose aziende minerarie, soprattutto quelle già in orbita Montedison, che erano diventate di importanza marginale per il gruppo chimico. Tra queste, si possono ricordare le miniere di zinco e piombo di Monteponi vicino a Iglesias e quelle di mercurio del Monte Amiata. Ma l’Egam non si limitò a operare nel settore minerario: acquisì il controllo dell’acciaieria Cogne di Aosta e del comparto siderurgico della Breda, e nel 1974 controllava 47 aziende con un totale di ben 32mila dipendenti. La maggior parte delle attività marcate Egam erano in perdita, ed Einaudi si guadagnò dalla stampa l’appellativo di “mister deficit”. Einaudi era legato all’allora ministro delle Partecipazioni statali Flaminio Piccoli e sembra che la rapidissima crescita dell’Egam fosse finalizzata a creare un ente pubblico che Piccoli potesse utilizzare per guadagnare consensi nella lotta tra le varie correnti della DC. Nel 1976 però l’insolvenza della Villain e Fassio, una società acquisita dall’Egam, provocò la rimozione di Einaudi dalla presidenza dell’Ente, che fu liquidato. Le sue attività minerarie furono rilevate dall’Eni, che le gestì fino ai primi anni Novanta, le rimanenti attività confluirono nell’Iri; la sola operazione di liquidazione costò allo Stato ben 550 miliardi di lire.
L’Efim (Ente Partecipazioni e Finanziamento Industrie Manifatturiere) è stato una holding – la terza in ordine di grandezza – del sistema delle partecipazioni statali. Era nato nel 1962 come Ente Autonomo di Gestione per le Partecipazioni del Fondo di Finanziamento dell’Industria Meccanica (Fim) e cambiò nome nel 1967. L’Efim diventò ben presto un ente polisettoriale attivo soprattutto nel Mezzogiorno. La sua situazione finanziaria fu sempre precaria, a causa di un indebitamento finanziario che, negli anni Ottanta, era superiore al fatturato. Come conseguenza di investimenti diversificati senza una coerenza apparente e della sua politica di acquisizioni di aziende considerate poco appetibili dai privati o dagli altri enti statali, l’Efim si guadagnò la fama di “ente spazzatura”. Quando l’ente fu messo in liquidazione nel 1992, i debiti ammontavano a circa 18mila miliardi di lire.
Nel 1962 si apre la stagione del centro-sinistra che rompe il legame con gli ideali della ricostruzione, del rigore einaudiano e di una politica “onesta” e che conduce l’Italia repubblicana alla concentrazione della grande industria nella mano pubblica, all’avvio delle politiche economiche inflattive, all’illiceità nell’amministrazione dello Stato e all’appiattimento della cultura e dell’informazione. Una parte di responsabilità dell’immobilismo del centro-sinistra va attribuita al capitalismo italiano, che fa di tutto per indebolire l’azione di Governo. Fuga di capitali, crisi della Borsa, riduzione degli investimenti sono duri colpi portati al centro-sinistra. L’opposizione a un’efficace politica di riforme e i costanti rigurgiti reazionari trovano, inoltre, terreno fertile nella burocrazia dello Stato, per la quale democrazia e riforme sono concetti poco congeniali (Ginsborg, 1989). Giova ricordare che, ancora nel 1973, il 95% dei funzionari di grado superiore era entrato in servizio durante il fascismo.
Quando, negli anni Sessanta, il sindacato, sospinto dalla base che richiedeva aumenti salariali, viene “riportato dentro le fabbriche”, si trova impreparato a gestire in modo corretto il proprio ruolo; non è capace di valutare la necessità di bilanciare le richieste con i vincoli della competitività e con la tipologia delle imprese e accetta ogni forma di corporativismo. La correttezza della trattativa sindacale viene anche inquinata dal frazionamento del fronte padronale, che vede, sistematicamente, le partecipazioni statali chiudere le trattative con l’accoglimento delle rivendicazioni sindacali.
Nel 1963 si verifica una prima battuta d’arresto dell’espansione economica post-bellica, causata dalle rivendicazioni salariali, dalla forte crescita dei consumi – che porta i prezzi al rialzo – e dal peggioramento della bilancia dei pagamenti. Nel 1969 la protesta operaia nasce dalla necessità di trasferire anche ai lavoratori parte del reddito di cui avevano fino ad allora beneficiato solo le imprese, ma, successivamente, la forte spinta al salario, diventato una sorta di variabile indipendente del sistema economico, e la cattiva politica monetaria del Governo saranno causa di un’iperinflazione che arriverà, negli anni Settanta, a superare il 20%. Di converso gli scioperi “dell’autunno caldo” del 1969, che pur raggiungono un’asprezza senza precedenti, spingono Cgil, Cisl e Uil sia all’unitarietà dell’azione sindacale, sia ad allentare in parte i legami con i partiti. Questi elementi producono da una parte un miglioramento delle relazioni industriali, dall’altra un rafforzamento del sindacato stesso, che diventa sempre più uno dei poteri con il quale venire a patti.
Un sinistro rumore di sciabole
Gli avversari della politica riformista sono sempre più aggressivi e ottengono che, nel giugno 1964, Moro rassegni le dimissioni. Il mese di luglio è tutto un fermento di incontri tra uomini politici e militari, di ipotesi di Governo di centro-destra oppure di centro-sinistra, di minacce di elezioni anticipate. Sempre in quel mese, a casa del democristiano Tommaso Morlino si tiene una riunione per discutere su come risolvere la crisi del primo Governo Moro, alla quale partecipano, oltre ad alcuni esponenti della DC (tra i quali Moro e Benigno Zaccagnini), anche il generale Giovanni De Lorenzo e il capo della polizia Angelo Vicari. Fu in occasione di quella riunione che Nenni affermò che si avvertiva in giro un «sinistro rumore di sciabole». La DC ribadisce la collaborazione con i socialisti può continuare solo a patto che vi sia la possibilità di mantenere in vita un’efficace economia di mercato. Il Psi, schiacciato tra le ipotesi di governi di centro-destra e il rischio delle elezioni anticipate che lo penalizzerebbero, è costretto ad accettare un Governo di centro-sinistra senza garanzie di riforme.
Il secondo gabinetto Moro (22 luglio 1964-23 febbraio 1966), impallinato dagli stessi democristiani grazie allo scrutinio segreto, e il terzo Moro (23 febbraio 1966-24 giugno 1968) sono stati tramandati alla storia come i Governi dell’immobilismo e dell’operosa passività. Lo statista, infatti, risolve il problema di una maggioranza di cui non si può fidare, rinunciando a portare in aula qualunque provvedimento di rilievo. La storia della transizione tra il primo e il secondo Governo Moro avviene in uno scenario estremamente sinistro. Nenni scriverà nelle sue memorie che la destra era intenzionata a creare un clima di tensione analogo a quello del 1960. Segni convoca Cesare Merzagora, presidente del Senato, per un incarico esplorativo; l’obiettivo è quello di approdare a un Governo tecnico di emergenza che evidenzi il fallimento dell’esperimento di centro-sinistra. Segni, inoltre, riceve al Quirinale, con grande risalto, il generale De Lorenzo, comandante dei carabinieri, dopo essere stato per sette anni a capo del Sifar. Il progetto di un Governo tecnico e l’incontro di Segni con De Lorenzo ricompongono i dissidi tra i partiti e i socialisti accettano di dare l’appoggio al Governo Moro senza alcuna contropartita. Per il momento il partito delle riforme economiche e strutturali è sconfitto.
Anni dopo, una commissione parlamentare d’inchiesta riassumerà così i fatti: «Nella primavera-estate del 1964, il generale De Lorenzo, al di fuori di ordini o direttive o semplici sollecitazioni provenienti dall’autorità politica, ideò e promosse l’elaborazione di piani straordinari da parte delle tre divisioni dell’Arma. Tutto ciò nella previsione che l’impossibilità di costituire un Governo di centro-sinistra avrebbe portato ad un brusco mutamento dell’indirizzo politico, tale da creare gravi tensioni fino a determinare una situazione di emergenza». È il cosiddetto piano “Solo”, che prende il nome dall’ipotesi di utilizzare “solo” l’Arma dei carabinieri; esso prevede una serie di iniziative, come l’occupazione della Rai e delle centrali telefoniche e il fermo di alcuni esponenti della vita politica e sindacale del Paese, allo scopo di consentire la costituzione di un Governo “stabile”.
Democristiani e socialisti non si fidano gli uni degli altri e, per controllarsi, non trovano migliore soluzione che correre all’occupazione delle “poltrone” delle aziende di Stato. Al IX congresso della DC (Roma, settembre 1964), dorotei e morotei, con il 48% dei voti, perdono la maggioranza assoluta, anche se riescono a far confermare Rumor alla segreteria. I fanfaniani ottengono il 21%, la destra l’11% e le sinistre (Base e Forze Nuove) il 20%. Il cartello degli Amici di Moro e Fanfani non c’è più e il partito è in balia del potere d’interdizione delle correnti. Questo potere negativo si evidenzia durante le elezioni del Presidente della Repubblica, perché Segni – ammalato – non è più in grado di rimanere al Quirinale. Le gelosie personali e la rissosità tra le correnti fanno sì che le candidature di Leone (candidato ufficiale) e di Fanfani (della dissidenza di sinistra), si elidano a vicenda e, il 29 dicembre 1964 viene eletto Presidente il socialdemocratico Giuseppe Saragat.
Il 21 agosto 1964 muore a Yalta Palmiro Togliatti; gli succede Luigi Longo, che conserva la struttura del partito sulla base della disciplina interna e del “centralismo democratico”, criteri che manterranno per anni il Pci in uno Stato di paralisi, eufemisticamente definita «dell’immobilismo dignitoso». Longo deve fare subito i conti con il terremoto che ha sconquassato la “casa madre”; infatti il 16 ottobre 1964 la Pravda pubblica, in poche righe, la notizia che Chrušcëv si è dimesso “per motivi di salute”. Prende così avvio la lunga stagione della restaurazione di Leonid Brežnev. Il popolo comunista non verrà “turbato” né da questo evento, né dall’ennesimo atto di brutalità sovietica, la repressione della Primavera di Praga e del tentativo di Alexander Dubcek, nel 1968, di dare al comunismo un volto umano.
Il 30 ottobre 1966 Psi e Psdi si fondono nel nuovo Partito Socialista Unificato (Psu); Nenni è presidente, Mario Tanassi e Francesco De Martino sono i segretari. Il X congresso della DC, tenuto a Milano nel novembre 1967, sembra del tutto sordo alle tensioni e ai fermenti che salgono dal Paese (nello stesso mese viene occupata e sgomberata dalla polizia l’Università Cattolica di Milano). I problemi che vengono agitati al congresso sono: come rintuzzare la concorrenza dei socialisti e come esprimere una leadership in grado di contrastare l’arroganza delle baronie correntizie. Impegno Democratico, schieramento di dorotei, morotei, fanfaniani e centristi, ottiene il 64,2% dei voti. Moro può portare il partito alle nuove elezioni politiche in una posizione di forza agli occhi dell’elettorato moderato, grazie alla ripresa economica del periodo 1966-1969 e alla posizione di “fermezza” tenuta nei confronti dei socialisti. Commenta Indro Montanelli: «[…] in quegli anni il Palazzo riuscì a realizzare la staticità della fibrillazione, un susseguirsi di crisi e tempeste in un bicchier d’acqua che non mutavano in nulla, pur con un carosello di governi e di nomi, l’assetto politico» (Montanelli, 2000).

25 marzo 2013
Eugenio Caruso
Tratto da